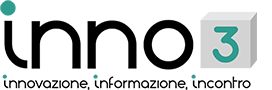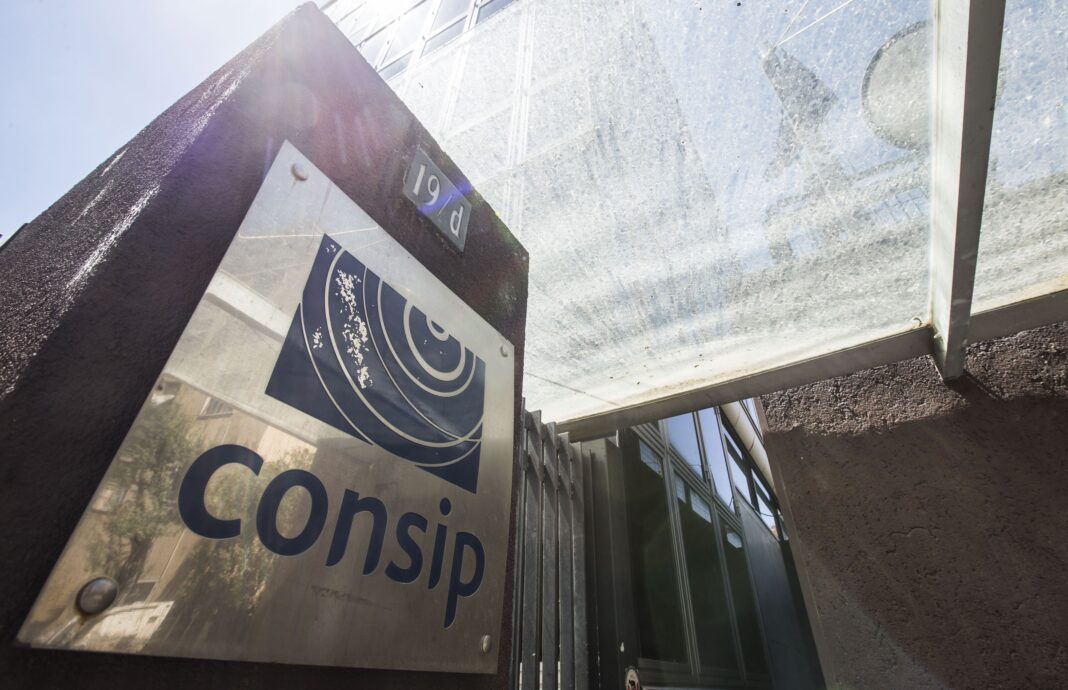Il rapporto tra pubblica amministrazione e imprese è legato ai temi di innovazione ma anche alla sostenibilità. E’ lo scenario entro cui Consip rilancia come strumento strutturato di dialogo la consultazione di mercato semestrale. Si tratta di un meccanismo che punta a rendere le gare pubbliche più efficaci e aderenti ai bisogni delle amministrazioni, ma anche più inclusive per le imprese – in particolare piccole e medie aziende e startup – che intendono contribuire con proposte innovative. L’iniziativa, che rientra nelle linee guida del Piano industriale 2025-2028, si configura come un tassello strategico per modernizzare i processi di procurement della PA e avvicinarli a logiche di co-progettazione.
Due momenti all’anno di ascolto del mercato
La novità principale è la definizione di due finestre fisse di consultazione, una in primavera e una in autunno. Ogni anno, infatti, nel periodo compreso tra febbraio e aprile e poi tra settembre e novembre, le amministrazioni potranno segnalare i propri fabbisogni operativi e progettuali attraverso la piattaforma dedicata, mentre le imprese avranno l’opportunità di rispondere con idee, soluzioni e proposte concrete. Non si tratta quindi di un dialogo occasionale, ma di un appuntamento periodico che crea un calendario stabile e prevedibile. In questo modo Consip si propone di anticipare il confronto, evitando che la discussione con il mercato avvenga soltanto al momento della pubblicazione di un bando, quando i margini per incidere sui contenuti della gara sono già ridotti.
I vantaggi…
L’iniziativa si fonda sull’idea che una consultazione preventiva generi una serie di vantaggi tangibili. Un primo beneficio è l’allineamento più stretto tra la domanda pubblica e l’offerta privata, con gare che riflettano i reali bisogni delle amministrazioni e le effettive capacità del mercato. A questo si aggiunge la possibilità di disegnare procedure più innovative, capaci di includere soluzioni tecnologiche avanzate e requisiti più aderenti alle dinamiche attuali delle imprese. Il nuovo approccio dovrebbe inoltre favorire l’apertura di spazi sperimentali per quelle realtà più piccole che, in passato, si sono spesso trovate escluse dai grandi appalti a causa di vincoli troppo rigidi o requisiti calibrati su operatori consolidati.

Sul piano sistemico, la consultazione contribuisce anche a rafforzare la trasparenza dei processi di acquisto pubblico, rendendo visibile a tutti come vengono raccolti e utilizzati i contributi del mercato. Infine, crea un senso di corresponsabilità: le imprese non sono soltanto fornitrici, ma diventano interlocutrici attive nella definizione delle regole di ingaggio.
…e le sfide
Accanto alle opportunità, Consip dovrà gestire alcune sfide critiche per rendere lo strumento realmente efficace. La prima riguarda la qualità degli strumenti di raccolta, come i questionari online (per PA e imprese), che non possono limitarsi a domande generiche o standardizzate: servono format capaci di stimolare risposte articolate, altrimenti il rischio è ottenere indicazioni troppo vaghe. Un secondo punto delicato è la rappresentatività della partecipazione.
Se a rispondere fossero soltanto le grandi amministrazioni centrali, il confronto perderebbe la ricchezza dei fabbisogni degli enti più piccoli, spesso portatori di esigenze particolari ma meno strutturati per farsi sentire. C’è poi il tema dell’analisi dei dati raccolti: ricevere centinaia di contributi ha senso solo se esiste un processo robusto di valutazione, capace di distinguere tra proposte realmente utili e semplici dichiarazioni d’intenti. Ulteriore sfida è la traduzione effettiva delle consultazioni in bandi concreti: se il dialogo preliminare non si riflettesse in gare coerenti, l’iniziativa rischierebbe di apparire come un esercizio di stile. Infine, anche le imprese devono dimostrarsi pronte a questo cambiamento: partecipare significa elaborare proposte credibili e misurate sulle logiche della PA, competenze non sempre disponibili all’interno di aziende di dimensioni ridotte.
La cornice del Piano industriale 2025-2028
La consultazione semestrale non è un intervento isolato ma – come detto – si inserisce nel quadro del Piano industriale 2025-2028 di Consip. L’obiettivo generale del piano è consolidare un modello di procurement orientato a digitalizzazione, innovazione e sostenibilità. In questa prospettiva, la consultazione rappresenta una sorta di “radar” che permette di intercettare le esigenze emergenti e orientare la progettazione delle gare, evitando che esse vengano calate dall’alto senza un’adeguata conoscenza del mercato. La logica è quella di costruire un procurement più modulare, flessibile e capace di adattarsi rapidamente all’evoluzione tecnologica e normativa.
Un aspetto centrale riguarda proprio il coinvolgimento delle piccole e medie imprese e delle startup. Queste realtà hanno spesso incontrato ostacoli nell’accesso ai bandi, sia per requisiti economici e dimensionali stringenti, sia per la difficoltà a interpretare le procedure complesse del procurement pubblico. Con la consultazione semestrale viene invece offerta loro la possibilità di presentare idee e modelli di servizio già nella fase iniziale, prima che i requisiti vengano definiti in modo vincolante. Ciò può tradursi in una maggiore apertura a tecnologie emergenti e in una riduzione dell’asimmetria informativa: le imprese possono comprendere con maggiore anticipo quali siano le direzioni di investimento della PA e tarare di conseguenza la propria strategia. Per l’ecosistema dell’innovazione italiano si tratta di un’opportunità significativa, che potrebbe incentivare la nascita di partnership pubblico-private più dinamiche.
Modalità di partecipazione e prospettive
Dal punto di vista operativo, la partecipazione alla consultazione richiede l’accesso alla piattaforma online predisposta da Consip. Amministrazioni e imprese, attraverso specifici spazi dedicati, potranno inserire fabbisogni, osservazioni e suggerimenti. Il calendario semestrale definisce con chiarezza le finestre entro cui intervenire, offrendo così certezza temporale e regolarità. Consip prevede inoltre momenti di confronto più strutturati, in cui discutere i risultati delle consultazioni e valorizzare le proposte più significative. La riuscita del progetto dipenderà quindi non solo dal numero di partecipanti, ma anche dalla qualità del dibattito che saprà generare.
La consultazione semestrale rappresenta pertanto anche una scommessa culturale. L’idea è che la qualità delle gare non derivi soltanto da procedure normative più rigide, ma dalla costruzione di un percorso di ascolto e dialogo. Le gare non sono più viste come eventi isolati, ma come l’esito di un processo relazionale che parte da lontano e che riconosce alle imprese un ruolo attivo. Se l’esperimento si dimostrerà solido, potrebbe costituire un modello replicabile anche a livello regionale e locale, aprendo la strada a una pubblica amministrazione più agile, capace di recepire stimoli esterni e pronta a trasformarli in politiche di acquisto concrete. La riuscita dipende ora dalla capacità del mercato di cogliere questa opportunità e di contribuire con proposte di qualità. La partecipazione non dovrebbe limitarsi alla compilazione di un questionario, ma trasformarsi in un impegno reale nella co-costruzione delle strategie di procurement. In questo modo la consultazione semestrale può diventare una porta d’accesso a gare pubbliche più efficaci e coerenti con le sfide della trasformazione digitale e della sostenibilità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA