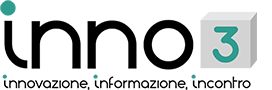L’intelligenza artificiale va in scena. Ma nel vero senso della parola. A teatro.
E’ cosi che, al teatro Oscar di Milano, ho assistito giovedì scorso a uno spettacolo della rassegna Versus (un format che non vuole insistere sulle contrapposizioni, ma sulle differenze di vedute per incontrare prospettive diverse) con due “attori” d’eccezione.
Titolo “Intelligenza artificiale. Ottimisti vs catastrofisti”.
Due attori, nei parti dell’ottimista e del catastrofista: Paolo Benanti (teologo, docente della Pontificia Università Gregoriana, unico membro italiano del Comitato Onu sull’intelligenza artificiale) e Telmo Pievani (filosofo, professore ordinario presso il Dipartimento di Biologia all’Università degli Studi di Padova).
Arbitro nella contesa: Enrico Bertolino, capace di trasformare la discussione in una vera pièce teatrale, ponendo ai due ospiti domande pungenti con quel tocco di comicità e di attualità che “alleggerisce” un argomento complesso.
Le arringhe dei due contendenti tra i massimi esperti di AI (scopertisi perfettamente intercambiabili nelle parti recitate man mano lo spettacolo procede) hanno toccato temi complessi legati all’AI: genesi, evoluzione, impatto, lavoro, opportunità, limiti, bias, paure, leggi, etica… davanti a un pubblico vario, dove la bellezza dei giovani studenti liceali ha fatto la differenza rispetto a un pubblico più maturo. Ma tutti in cerca di risposte.
Perché ne parlo?

Perché il teatro, luogo di cultura e di sapere dai classici all’arte contemporanea, ha messo in scena con sapienza, in poco più di un’ora, tutti i punti di attenzione di cui si parla quando si cita l’AI (“un tormentone quasi più della resilienza”, scherza Bertolino): la grande potenza muscolare dell’AI, la grande capacità di calcolo, la grande quantità di acqua ed energia che richiede, la sua capacità di elaborazione dati in tempi veloci trasformando anni in mesi, mesi in minuti, ma anche le grandi questioni filosofiche lasciate aperte, legate al significato di essere umani in un’epoca di incomprensibile complessità tecnologica, inarrestabile, da gestire con limiti, regole, sensibilità.
“L’AI va in difficoltà davanti ai Perché?”, come quelli ripetuti dei bambini nei primi anni di vita. Esordisce Pievani: “Non è detto che rispecchi i nostri valori, perché non è umana, non ha avuto 3 miliardi di anni per evolversi come l’uomo, non ha un corpo, non dorme mai, e come tale prende allucinazioni, non capisce il senso, il contesto, e preoccupa chi la controlla, chi la governa, in mano a potenti miliardari e non grandi associazioni pubbliche. Capire il senso è proprio il compito della nostra intelligenza, il nostro cervello è una spugna che si fa plasmare, l’uomo è imperfetto e per questo siamo creativi. L’AI non sa di non sapere tantissime cose”.
Ma nell’inverno demografico che ci attende, con una decrescita significativa della popolazione già nei prossimi anni, l’AI è una questione di necessità per rimanere competitivi, aiuta l’economia, la ricerca (i papiri di Ercolano recentemente decifrati dopo millenni), la medicina (mappatura genoma, vaccini in tempo record), il lavoro… “Con l’AI la tragedia del Tacoma Narrow Bridge (il ponte inaugurato nel 1940 nello stato di Washington, lungo poco meno del Golden Gate, crollato per oscillazioni del vento solo dopo 129 giorni per calcoli sbagliati, ndr) si sarebbe evitata?” esemplifica Benanti. “L’avventura di inventare sarà aiutata dall’AI? – si interroga -. Noi uomini non siamo stati capaci di creare insieme, la situazione drammatica della crisi climatica ne è una conferma, magari l’AI ci permetterà di farlo in futuro”.
Si esce dal teatro con molte domande aperte – una su tutte “L’AI diminuirà la nostra umanità o la completerà?” – ma con qualche certezza che il duo Pievani-Benanti nei ruoli mischiati rimarca.
L’AI è qui per restare, è potente, accelera lo sviluppo in moltissimi ambiti della vita dell’uomo ma richiede di essere governata da leggi ed etica, esige formazione e istruzione. “Serve definire regole chiare del gioco”.
Pievani: “Dovremo co-evolvere con l’AI, trasformare insieme, ma noi umani dobbiamo mantenerne il controllo. La risposta dell’AI deve essere sempre a una domanda che l’essere umano si è fatto: dove vogliamo finire?”
Benanti: “L’uomo ha bisogno di sognare un domani per averlo. E’ immorale generare promesse che non saranno mantenute”.
Una discussione intensa, bella, rimasta aperta, mai banale, che nel finale ha coinvolto il pubblico per alzata di mano dividendoli tra preoccupati e fiduciosi. Ottimisti e catastrofisti. Secondo voi chi ha primeggiato?
Post scriptum
Intanto fuori da teatro, nel mondo, il dibattito sull’AI non si ferma (come gli annunci milionari delle aziende durante la settimana).
In Europa sono entrati in vigore da febbraio i divieti previsti dall’AI Act, la legge europea sull’AI contente restrizioni allo sviluppo, alla commercializzazione e all’uso dell’intelligenza artficiale.
Mentre negli Usa questa settimana OpenAI è tornata alla carica con la richiesta di risolvere – nel piano di adozione dell’AI promesso dall’amministrazione Trump entro l’estate – le questioni legate ai diritti di autore per addestrare l’AI. Al momento OpenAI si trova coinvolta in numerose cause legali con titolari di diritti d’autore (tra cui testate giornalistiche), difendendosi argomentando che l’AI trasforma le opere originali in qualcosa di diverso dall’opera stessa. Per questo l’addestramento su opere coperte da copyright è considerato da OpenAI un’azione che rientra nell’ambito del “fair use“, per un accesso illimitato ai dati per sviluppare modelli sempre avanzati di AI. Ovvio che il dibattito sul governo dell’AI sia acceso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA