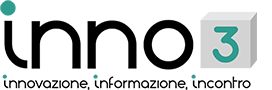European Accessibility Act (Eaa) è una direttiva europea che mira a garantire l’accessibilità di prodotti e servizi digitali al pubblico, promuovendo l’inclusione delle persone con disabilità e abbattendo le barriere che ostacolano la piena partecipazione sociale ed economica. Lo scopo, in altre parole, è quello di rendere accessibili al consumatore i contenuti ad un più ampio numero di persone con disabilità, tra cui cecità e ipovisione, sordità e perdita dell’udito, limitazioni motorie, disabilità del linguaggio, fotosensibilità nonché combinazioni di queste, e migliorare in parte l’accessibilità anche per chi ha disturbi dell’apprendimento e/o limitazioni cognitive.
La normativa si fonda sui quattro principi cardine delle linee guida Wcag (Web Content Accessibility Guidelines): percepibile ovvero le informazioni e i componenti dell’interfaccia devono essere presentabili agli utenti in modi che possano percepire, anche attraverso canali alternativi (ad esempio, testi alternativi per immagini); operabile ovvero tutti i componenti e la navigazione devono poter essere utilizzati da chiunque, anche senza mouse o con tecnologie assistive; comprensibile ovvero le informazioni e il funzionamento dell’interfaccia devono essere chiari e comprensibili per tutti gli utenti; robusto ovvero i contenuti devono essere interpretati in modo affidabile da una vasta gamma di dispositivi, inclusi quelli assistivi.
La situazione in Italia
In Italia, la direttiva è stata recepita con il d.lgs. 82/2022 che è entrato in vigore il 28 giugno scorso e introduce obblighi rigorosi per le aziende che operano sul mercato italiano ed europeo rivolto ai consumatori. Il tema dell’accessibilità nel nostro Paese non è per altro una novità. ll quadro normativo italiano era già caratterizzato dalla legge n. 4/2004, nota come Legge Stanca e successive modifiche, che ha rappresentato il primo riferimento organico in materia di accessibilità digitale. Questa legge, inizialmente rivolta al settore pubblico, è stata successivamente estesa ad alcune categorie di aziende private, in particolare quelle con fatturato superiore a 500 milioni di euro o appartenenti a gruppi societari di grandi dimensioni. Il decreto 82/2022, invece, si concentra principalmente sulle Pmi che offrono prodotti e servizi al pubblico, imprese quindi che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Sono esentate, al momento, le microimprese anche se offrono i servizi (ma non i prodotti) indicati dalla normativa ovvero le imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Accessibilità e leggi, aspetti critici
Un aspetto critico è proprio la parziale sovrapposizione delle due normative. Infatti il d.lgs. 82/2022 recependo la direttiva europea, ha abrogato solo in parte la Legge Stanca, lasciando in vigore alcune sue disposizioni, soprattutto per quanto riguarda gli obblighi delle pubbliche amministrazioni e delle grandi imprese. Questo obbliga le aziende a confrontarsi con un sistema di regole stratificato e in evoluzione. La coesistenza di queste normative richiede quindi alle aziende una particolare attenzione nell’identificare quale regime normativo sia applicabile alle proprie attività, considerando che i requisiti tecnici e le modalità di verifica potrebbero differire tra i due sistemi normativi (per esempio la Dichiarazione di Accessibilità è un obbligo della Legge Stanca, mentre il d.lgs. 82/2022 prevede in generale “… informazioni necessarie… indicando le modalità con le quali sono soddisfatti requisiti di accessibilità” e che tali “… informazioni sono messe a disposizione del pubblico in forma scritta e orale, anche in modo da essere accessibili a persone con disabilità”).
Accessibility Act, gli impatti
L’impatto dell’Accessibility Act è particolarmente rilevante in numerosi settori, tra questi si possono indicare:
- E-commerce: tutti i siti di vendita online, le app mobili e i sistemi di pagamento dovranno essere accessibili;
- Banche e servizi finanziari: Atm, home banking, app di pagamento e servizi digitali per i consumatori dovranno garantire l’accessibilità a tutte le categorie di utenti, con particolare attenzione alle persone con disabilità visive o motorie;
- Trasporti: biglietterie automatiche, siti di prenotazione, totem, app di viaggio e informazioni digitali su orari e percorsi dovranno essere fruibili senza barriere;
- Media intrattenimento digitali: produttori di smartphone, computer e sistemi operativi, nonché provider di servizi telefonici, TV digitale, piattaforme di streaming ed editoria digitale (e-book) e dispositivi connessi dovranno rispettare i requisiti di accessibilità;
- Sanità ed education: portali di prenotazione, referti online, piattaforme di e-learning e servizi informativi al consumatore, dovranno essere progettati per essere utilizzabili da tutti.
In questo contesto si ritiene utile formulare alcune riflessioni in merito all’impatto dell’Accessibility Act sulle aziende italiane, evidenziando i possibili aspetti positivi e quelli negativi. Da un lato, infatti, le aziende che investiranno seriamente sull’accessibilità potranno migliorare la propria reputazione dimostrando un impegno concreto in tema di responsabilità sociale d’impresa. Inoltre il dover adottare soluzioni tecnologiche per garantire l’accessibilità dovrebbe stimolare l’innovazione e la qualità dei servizi digitali, con ricadute positive anche per utenti senza disabilità. Dall’altro lato, l’adeguamento, soprattutto per le Pmi, potrà comportare investimenti significativi in formazione, aggiornamento di piattaforme digitali e revisione dei processi interni. Il legislatore ha però previsto un elemento di mitigazione, da usare con la dovuta attenzione (“non è un liberi tutti”): i requisiti di accessibilità si applicano nella misura in cui la conformità o non richieda una modifica sostanziale di un prodotto o di un servizio tale da comportare la modifica sostanziale della sua stessa natura oppure non comporti l’imposizione di un onere sproporzionato agli operatori economici interessati. Inoltre, come detto sopra, la coesistenza di più fonti legislative e la necessità di interpretare correttamente gli standard tecnici possono generare incertezza e difficoltà applicative, soprattutto per le realtà meno strutturate. Infine, occorre sottolineare i classici rischi di sanzioni amministrative pecuniarie che le normative europee sono solite comportare.
L’Accessibility Act forse non rappresenta una svolta culturale e normativa attesa la previgente normativa, ma indubbiamente chiama le aziende italiane a un cambio di paradigma: non più considerare l’accessibilità come un obbligo formale, ma come un’opportunità di crescita, innovazione e inclusione. Il percorso di adeguamento non è privo di ostacoli, ma dovrebbe portare benefici duraturi sia alle imprese, sia alla società nel suo complesso. L’attenzione alle sanzioni e alla reputazione impone quindi alle aziende di agire con tempestività e visione, per non perdere competitività in un mercato sempre più attento ai diritti di tutti.
—
Valerio Vertua è avvocato cassazionista attivo nei settori del diritto tributario, societario, dell’informatica e delle nuove tecnologie. Collabora con le Cattedre di Informatica Giuridica della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA