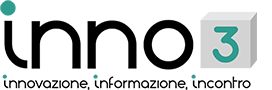L’industria sta entrando in una nuova fase in cui la generative economy ridefinisce il modo di innovare, produrre, e formare competenze, tenendo al centro il controllo dei processi che caratterizzano le diverse industry. In questo scenario la proposta di Dassault Systèmes si pone nel suo insieme come un vero e proprio “sistema operativo per il business”, capace di connettere progettazione, produzione, dati e simulazione, supply chain e maintenance dei sistemi in un ecosistema che abbraccia sostenibilità, virtual twin e sense computing. L’obiettivo è riuscire a sfruttare il potenziale dei sistemi digitali, lungo tutto il ciclo di vita dei prodotti e delle risorse che servono alle industry.
Ne parliamo con Gian Paolo Bassi, Svp Mainstream Innovation & Customer Role Experience – Dassault Systèmes. Il primo riferimento è quasi per “necessità” legato al percorso di Solidworks: “Stiamo celebrando il trentesimo anniversario dalla prima versione – racconta Bassi – che coincide con un momento chiave che ci vede impegnati ad aiutare i clienti ad introdurre il potenziale dell’intelligenza artificiale nei flussi di lavoro ingegneristici” e Dassault Systèmes ha iniziato a sperimentare tecniche di machine learning molto prima dell’attuale boom dell’AI generativa. Prosegue: “Dieci anni fa avevamo già sviluppato i primi ‘accelerator’, in grado di sfruttare algoritmi di apprendimento automatico. Oggi invece, abbiamo rilasciato ufficialmente quattordici nuove funzionalità basate sull’AI all’interno di Solidworks: strumenti generativi, assistivi e predittivi”.
L’AI per valorizzare la conoscenza e accelerare i processi
L’impatto sull’industria italiana, costituita in larga parte di piccole e medie imprese manifatturiere, è evidente. “L’intelligenza artificiale entra in ogni fase del ciclo di vita del prodotto: dalla fase di innovazione fino al bid commerciale, dal design alla simulazione, fino al decommissioning, cioè alla gestione del fine vita. Significa, ad esempio, capire anche come smontare un macchinario per riutilizzarne i componenti o ricondizionarlo per allungarne la vita”. Nel cuore della proposta di Dassault Systèmes c’è Aura, chatbot conversazionale sviluppato in collaborazione con la società francese Mistral che va ben oltre la semplice proposta di un large language model. Chiarisce Bassi “Il suo compito è consentire di interagire con, e trarre vantaggio da, una costellazione di agenti verticali: modelli specializzati per il design, per la produzione, per la simulazione. Che per questo noi chiamiamo agenti di concertazione”.
Questa architettura risponde a un’esigenza precisa: permettere alle imprese di integrare conoscenze diverse, mantenendo il controllo sulla proprietà intellettuale. “Aura porta al progettista due tipi di conoscenza – spiega Bassi -. Da un lato quella globale, che deriva da pubblicazioni scientifiche, paper universitari, best practice a livello mondiale. Dall’altro lato la conoscenza interna, che rappresenta il vero patrimonio delle aziende”. Un valido esempio quindi di come l’AI possa diventare strumento per recuperare, catalogare e trasmettere alle nuove generazioni questa conoscenza. Il discorso si allarga a una questione strategica. “Negli Stati Uniti, così come in Europa, il problema più grande dei programmi di reindustrializzazione è la perdita di know-how manifatturiero e se vogliamo riportare capacità produttive nel Paese, dobbiamo avere strumenti che aiutino a preservare e trasmettere il sapere tecnico. L’automazione e l’intelligenza artificiale servono anche a questo”. E secondo Bassi, la vera sfida è combinare oggi due livelli di conoscenza: “Un ingegnere che deve introdurre i materiali compositi nella propria azienda e non ha esperienza, grazie a un modello linguistico specializzato può accedere in pochi secondi alla sintesi dello stato dell’arte mondiale, ma ancora più importante è la possibilità di allenare Aura sui documenti interni dell’impresa, inclusi disegni e schemi tecnici. Dove risiede la vera proprietà intellettuale”.
Un altro campo di applicazione riguarda i processi commerciali. Prosegue Bassi: “Una commessa può valere dieci milioni di euro e la precisione nel bid è cruciale: sbagliare significa perdere la gara o rischiare penali”. L’AI, attraverso Aura, permette di analizzare lo storico delle offerte, valutare le condizioni logistiche, calcolare il costo dei materiali in base alle fluttuazioni di mercato e persino considerare le possibilità di trasporto: “Significa integrare conoscenze ingegneristiche, commerciali e logistiche in un’unica piattaforma di decisione”. Le applicazioni non si fermano qui. “Nella modellazione parametrica, gli errori di collegamento – i cosiddetti missing links – sono un problema noto da decenni che l’AI può correggere automaticamente, evitando perdite di tempo e rischi di errore”. Un altro esempio ancora è la generazione automatica di drawings. “Abbiamo rilasciato una funzionalità che produce disegni tecnici in modo automatico – spiega -. Con un’accuratezza che consente di ridurre drasticamente il tempo che gli ingegneri devono spendere nella documentazione, liberandoli per attività a maggior valore”. La simulazione è un altro campo in cui l’AI sta cambiando le regole e con l’AI la simulazione diventa accessibile anche a chi non ha competenze specialistiche. “Basta chiedere ad Aura di predisporre un crash test e il sistema genera il modello, integrando vari scenari di design study”, così come enormi sono i vantaggi anche nel 3D printing. La supply chain è un ulteriore ambito in cui l’AI si rivela decisiva. “Oggi non parliamo più di integrazione verticale della fabbrica, ma di integrazione verticale della supply chain”, sottolinea Bassi. E con l’AI è possibile condividere solo i dati strettamente necessari.
Tutti questi esempi trovano coerenza nella visione aziendale che prevede la possibilità per l’industria di imparare dai dati che ha a disposizione e dai suoi processi rigenerativi. “E tutte le nostre soluzioni – da Catia a Solidworks – condividono un data model comune che permette di applicare l’intelligenza artificiale in modo consistente lungo l’intero ciclo di vita del prodotto. Si parla di integrazione profonda nel cuore dei dati industriali”.
3DExperience Platform, sistema operativo per il business
Gian Paolo Bassi sintetizza la postura industriale di Dassault Systèmes con un’immagine chiara: “Le soluzioni trovano coerenza applicativa all’interno della 3DExperience Platform che si propone, appunto, come sistema operativo per il business” in un perimetro che tiene insieme progettazione, produzione, gestione dei processi, collaborazione estesa e sicurezza, con un obiettivo esplicito: “Aiutiamo i clienti a creare intellectual property e a preservarla”. Ed in un contesto in cui la proprietà intellettuale è l’asset più prezioso, la “promessa” di piattaforma viene misurata dalla capacità di valorizzarla senza sacrificare l’apertura collaborativa che l’industria richiede.

Significa tenere connessa in continuità la catena del valore – dal pensiero a monte alla progettazione, dai processi di engineering quindi, alla produzione, fino a vendite, marketing etc., – trasformando il modo in cui si inventa, si impara, si produce e si scambia. “Significa quindi abbracciare insieme operations e modelli di business per riposizionare ruoli e relazioni nell’ecosistema, abilitando virtual twin experiences con accuratezza scientifica”, dettaglia Bassi. Con un’apertura che trova nella declinazione in cloud un abilitatore digitale coniugato con l’attenzione per la sicurezza “per una trusted business experience as a service erogata con l’obiettivo esplicito di abbattere i silos, capitalizzare il know-how e democratizzare la data science lungo l’ecosistema”. Se la sicurezza è la condizione, la continuità digitale è il mezzo. E per questo la piattaforma non vive “isolata” ” ma assimila i dati anche dai Cad concorrenti e li traduciamo in un linguaggio comune, perché senza una lingua condivisa non è possibile abilitare il paradigma della collaboration”.
Il senso dell’architettura è chiaro: la creazione di valore non è più nel singolo oggetto, ma nell’esperienza che connette ruoli, dati, conoscenze e processi. “La platform, in questa visione, va ben oltre l’idea di un Plm ‘esteso’, è piuttosto tessuto operativo che porta modellazione/simulazione/information intelligence nel cuore dei processi, fino a costruire gemelli virtuali condivisi fra attori diversi”.
La piattaforma serve quindi anche ad “accedere e applicare conoscenza e know-how ad alta velocità” e a “testare infinite possibilità”, portando nel core operativo modellazione/simulazione/dati e consentendo scelte che bilanciano vincoli spesso in contraddizione (prezzo, emissioni, sicurezza) con l’AI applicata ai virtual twin che aiuta a navigare complessità ad alta dimensionalità e a fornire una nuova sintesi decisionale.
Il nodo più duro non è tecnico. “L’ostacolo è il change management, la frammentazione organizzativa e tutti su una piattaforma integrata è sempre difficile, serve allora introdurre innovazioni un passo alla volta” e integrare ciò che già esiste, in particolare i pilastri Erp e Mes. La letteratura istituzionale riconosce questa complessità: il percorso di Dassault Systèmes dal 3D/Dmu (utilizzo di modelli digitali tridimensionali, creati tramite software Cad, per la rappresentazione virtuale di un prodotto o sistema prima della sua realizzazione fisica) al Plm è guidato proprio dalla necessità di affrontare requisiti sofisticati di gestione del cambiamento, collaborazione industriale e lavoro cross-enterprise, mentre l’ampliamento del portafoglio – simulazione realistica, manifattura digitale, Pdm, collaborazione – ha dato gli strumenti per farlo su scala. Un ultimo punto: “Gli imprenditori – ricorda Bassi – perseguono competitività: accuratezza del bid, time-to-market, costo e – sempre più – sostenibilità”. La piattaforma rende calcolabili questi trade-off mettendo i Kpi in tensione controllata: prezzo vs. peso, emissioni vs. sicurezza, lead-time vs. qualità. “È qui che l’AI “di piattaforma” (non un add-on) e i virtual twin offrono una sintesi navigabile della complessità – è l’importante differenza fra ottimizzare localmente un reparto e orchestrare globalmente una filiera”.
Lo scenario digital twin
Se l’AI e la 3DExperience Platform rappresentano già oggi la base di un nuovo modo di lavorare, in evoluzione continua i gemelli virtuali aprono a scenari ancora più disruptive, anche in ambiti inattesi grazie alla possibilità di replicare digitalmente organi, impianti, fabbriche e sistemi complessi, trasformandoli in laboratori per simulare e validare decisioni. Prosegue Bassi: “Partiamo dalla sanità, perché è probabilmente il settore più soggetto a una trasformazione profonda. Quando un chirurgo affronta un intervento cardiaco, può conoscere il paziente in modo perfetto. E Dassault Systèmes ha sviluppato progetti come il Living Heart, che simula un cuore con caratteristiche specifiche – età, Dna, storia clinica”. I gemelli virtuali spostano così la medicina dalla logica standardizzata a quella personalizzata, permettendo di ridurre rischi e tempi. “Stiamo lavorando anche per digitalizzare i clinical trial – aggiunge Bassi -.Testare farmaci su avatar digitali invece che su persone reali riduce enormemente i rischi. È lo stesso principio che nell’automotive ha portato ai crash test virtuali”. In Italia l’adozione dei gemelli in sanità è tuttavia ancora a macchia di leopardo: “Ma nella dentistica e nella chirurgia maxillo-facciale tanto è già digitalizzato e sensibile al tema. Il problema resta quindi la scala: serve estendere queste pratiche, abbassare i costi e formare personale”. Se in sanità la strada è in questo senso in costruzione, nella manifattura i virtual twin sono già realtà. “Oggi, per esempio, anche il virtual commissioning è prassi: non si investono milioni in automazione senza simulare fabbriche, robot e processi. Ed In Italia c’è molta competenza e l’adozione cresce rapidamente”. Oltre all’efficienza, i gemelli virtuali sono poi catalizzatori di sostenibilità, riducendo prototipi fisici, consumi e sprechi.
Verso il sense computing
Oltre i gemelli digitali, che consentono di replicare fedelmente, fabbriche, sistemi complessi (e in sanità anche gli organi) per simulare processi e gli effetti delle decisioni, il passo successivo è quello di estendere la digitalizzazione oltre l’efficienza tecnica. Spiega Bassi: “Se i virtual twin permettono di ridurre rischi e costi grazie a modelli scientificamente accurati, il sense computing porta la simulazione su un piano diverso: quello della percezione umana. In questo modo, la progettazione non riguarda più soltanto prestazioni e durabilità, ma anche le emozioni e le sensazioni che un prodotto è in grado di generare”. Si vuole quindi tentare di virtualizzare anche l’esperienza, ma in questo caso “Non basta più verificare parametri di resistenza o tolleranze, bisogna chiedersi come il prodotto viene percepito dal consumatore, quali emozioni suscita”.
Per questo Dassault Systèmes definisce il sense computing come la possibilità di creare “interazioni naturali tra esseri umani ed esperienze digitali, usando sensi, comportamenti, emozioni”. È il pilastro per cui sono stati pensati i nuovi 3D Univ+Rses, ambienti che uniscono AI, simulazione e intelligenza esperienziale e permetteranno ai clienti di creare il gemello virtuale di ogni cosa virtualizzando l’intero ecosistema.
Per l’Italia, il settore fashion è il primo terreno fertile. Bassi: “Pensiamo a una casa di moda: non progetta solo un abito, ma un’esperienza. Deve simulare come sarà indossato e percepito dal consumatore” e il sense computing permette di replicare tessuti, cadute dei materiali e sensazioni tattili, riducendo tempi e costi di collezioni e prototipi. Nell’automotive, pure, la customer experience è fatta di emozioni: “Il suono del motore, la morbidezza dei materiali, la fluidità dell’interfaccia digitale. Tutto questo può essere simulato prima della produzione”.Così che il virtual test drive si possa arricchire di dimensioni emozionali e sensoriali.
Lo stesso vale per il design industriale. “Un prodotto italiano non è mai solo funzionale: porta con sé un messaggio di stile ed ergonomia”, osserva Bassi. Anticipare la user experience significa evitare errori, ridurre tempi di redesign e aumentare l’accettazione sul mercato. “Se si riesce a simulare come un consumatore percepirà un capo o l’abitacolo di un’auto, si ridurranno anche i rischi e si accorceranno i cicli di sviluppo”, aggiunge Bassi. Validare emozioni prima della produzione fisica significa allora ridurre sprechi e prototipi, contribuendo a modelli più sostenibili.
Il valore delle competenze
Il potenziale degli strumenti digitali apre scenari in cui progettazione ed emozioni si intrecciano, ma è anche evidente che la padronanza di questi strumenti richiede nuove competenze. Dalla moda all’automotive, la capacità di simulare sensazioni e percezioni si aggiunge alle competenze ingegneristiche tradizionali, trasformando i processi creativi e industriali. “Perché queste innovazioni possano radicarsi davvero, occorre però formare professionisti in grado di muoversi tra AI, simulazione e user experience”. È qui che entra in gioco la sfida educativa, con programmi mirati a colmare il divario di competenze e a favorire il legame tra giovani talenti, università e imprese.
“Il problema delle competenze è globale – afferma Bassi -. “Le tecnologie evolvono velocemente, ma la capacità delle persone di padroneggiarle non cresce con la stessa rapidità”. Per Dassault Systèmes la risposta è nel learning by doing. “Non basta la teoria: bisogna progettare, costruire, sbagliare, riprovare. È il modo più efficace per formare nuove generazioni di ingegneri e tecnici”, spiega Bassi. Su questo principio è stato lanciato a febbraio Solidworks Skillforce, programma che mette studenti e giovani professionisti di fronte a casi reali, con la possibilità di affrontarli grazie alla disponibilità di strumenti di progettazione avanzati e scenari industriali concreti. Solidworks Skillforce prevede infatti anche la fornitura di licenze delle applicazioni Solidworks gratuite agli studenti che partecipano a tirocini per acquisire esperienza lavorativa nel mondo reale. “Il modello Dassault Systèmes funziona perché, inoltre, accorcia la distanza tra università e imprese, dando ai ragazzi la possibilità di misurarsi subito con il mondo del lavoro con Dassault Systèmes come “testa di ponte”, tra gli ambienti accademici e le realtà sul territorio”. A questo si aggiunge l’attività della Fondation Dassault Systèmes, che sostiene progetti educativi e culturali in Europa e nel mondo, sempre con un approccio esperienziale. “La formazione è la chiave della competitività – chiude Bassi-. In Italia, dove il manifatturiero è fatto di Pmi e di eccellenze artigiane, servono strumenti che rafforzino il legame tra università, giovani talenti e imprese locali”. La sfida non è quindi solo tecnologica, ma culturale: serve investire nella crescita delle persone, e anche nelle startup per permettere alle innovazioni digitali – dall’AI al sense computing – di generare realmente patrimonio diffuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA